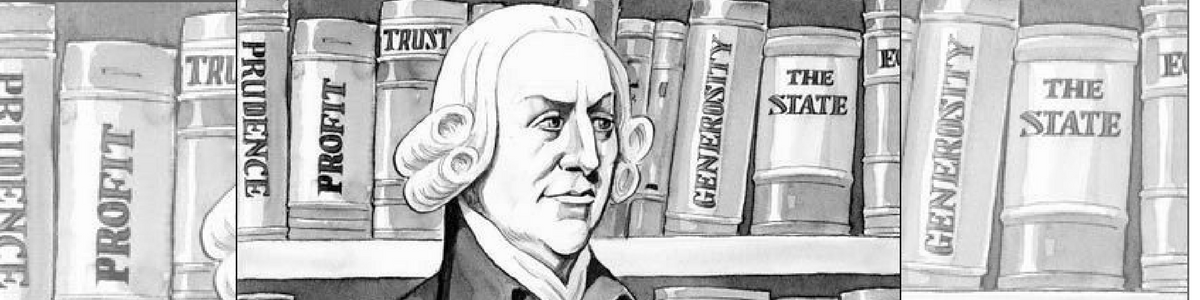L’estratto dell’intervento di Corrado Ocone, con il quale il direttore scientifico della Fondazione Einaudi aprirà l’edizione della Scuola di Liberalismo 2018 di Roma (per saperne di più, vai su www.scuoladiliberalismofle.it)
“Non sarebbe un’esagerazione dire che la teoria sociale comincia con – ed ha un proprio oggetto solo a causa della – scoperta che esistono strutture ordinate, le quali sono il prodotto dell’azione di molti uomini, ma che non sono il risultato di una progettazione umana”. Così scrive Friedrich von Hayek, sistematizzando un concetto che aveva già enucleato in diverse sue opere precedenti, nel primo dei tre volumi (“Regole e ordine”) di Legge, legislazione e libertà (1973).
In particolare, Hayek pensa a istituzioni come il diritto e la lingua, ove l’idea che esse siano dovute all’azione umana ma non nascano da un programma formulato dagli uomini è abbastanza pacifico. Non così nella scienza economica ove, contro quella che l’economista austriaco giudica un’evidenza, l’idea dominante è che la programmazione e la panificazione, cioè i progetti umani, possano plasmare la realtà.
Non senza aver avvertito che il termine “ordine”, in uso almeno dai tempi di Agostino nella teoria politica, sia abbastanza equivoco, richiamando concezioni autoritarie dell’azione, Hayek parla perciò di un ordine spontaneo che caratterizza molte istituzioni umane e che si autogenera e si forma per evoluzione. L’espressione “ordine spontaneo”, aggiungo io, è comunque in sé ossimorica, generando nei fatti la spontaneità una struttura o un modello che è sempre in disequilibrio, e che cioè è un mix di ordine e disordine.
E guai se così non fosse: la libertà umana non sopporta l’anarchia sociale ma nemmeno la “società perfetta”: una buona dose di anarchia, imperfezione e irregolarità è l’humus ideale per la nostra vita. Ma andiamo con ordine.
Quello che qui si vuole ora affermare è che l’ordine spontaneo, che Hayek designa anche con il nome greco di cosmos, distinguendolo dalla taxis che è il risultato di un’azione umana volontaria, è un’idea che attraversa la modernità pur non riuscendo mai a contrastare le tendenze progettuali, razionalistiche e regolistiche in essa predominanti.
La ritroviamo sia nel filone dell’illuminismo scettico ma fortemente pragmatico degli scozzesi soprattutto, sia, e non deve meravigliarci, nelle correnti variamente idealiste e storicistiche che hanno avuto la loro roccaforte soprattutto fra Italia e Germania nei secoli XVIII e XIX (e nei paesi anglosassoni solo nei decenni a cavallo fra i due secoli).
La cosiddetta “scuola scozzese del senso comune”, da Adam Ferguson ad Adam Smith passando per il grande David Hume, fu molto influenzata da un poema satirico di un olandese operante in Inghilterra, Bernard de Mandeville, che fu pubblicato per la prima volta anonimo nel 1705: La favola delle api, ovvero: vizi privati, pubbliche virtù.
È questo il primo libro influente in cui, attraverso una sorta di apologo in versi, viene messo in evidenza il concetto che lega la ricchezza e vitalità, soprattutto ma non solo economica, di una comunità, qui simboleggiata da un florido alveare, al libero e controllato dispiegarsi di passioni, vanità, ambizioni, legate all’interesse privato.
Quando l’alveare decide di divenire virtuoso, mettendo al bando il lusso, l’avidità, la brama di potere, onori, glorie e ricchezze, di un colpo esso decade prima nella povertà generale e poi si sgretola. Poco più di mezzo secolo dopo, Adam Smith, nel suo capolavoro (La ricchezza delle nazioni) scriverà la sua nota considerazione che “non è certo dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci spettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi hanno cura del proprio interesse”.
È come se la società fosse guidata da una mano invisibile che tutto fa per accomodare le passioni individuali nel modo più consono alla vita della comunità. Anche se si tratta di una rottura netta con la declinazione virtuosistica e pauperistica del cristianesimo che si era affermata nel medioevo, non è difficile intravedere in questo concetto una sorta di laicizzazione dell’idea di Provvidenza.
Un processo che in verità era iniziato già con il cattolico Giambattista Vico che, distinguendo fra un mondo tutto nostro e fatto da noi, quello sociale, dal mondo naturale, aveva limitato l’intervento di Dio nel mondo umano solo all’immissione in esso di una sorta di regola generale, la Provvidenza appunto, tesa a comporre le libere iniziative individuali secondo un fine di civilizzazione (il concetto di eterogenesi dei fini, secondo l’espressione usata nella sua Etica, del 1886, dallo psicologo e filosofo empirico tedesco Wilhelm Wundt, è in Vico illustrata con espressioni poetiche tipo: “sembravano traversie ed eran in fatti opportunità”) . In questo modo, Vico salvava libero arbitrio e potestà divina, ma soprattutto rendeva forse per la prima volta quasi del tutto immanente il concetto di Provvidenza.
Prima che Hegel riprendesse il ragionamento di Vico, era stato però Immanuel Kant a esprimere in modo compiuto il nesso che unisce la civiltà e il progresso umani al libero dispiegarsi (entro ovviamente ad un regime di regole e leggi) delle passioni egoistiche e degli interessi privati. In Idea di una storia universale da un punto di vista cosmopolitico (1784), anche se il tutto sembra essere inserito nel quadro di una sorta di naturalismo, emerge un provvidenzialismo non troppo diverso da quello vichiano (forse con un più accentuato teleologismo dovuto alla mentalità illuministica che comunque era propria del pensatore di Koenigsberg).
Soprattutto, in Kant emerge con nettezza, da una parte, l’elemento antropologico della questione, essendo egli dice l’uomo caratterizzato da socievole insocievolezza; dall’altra, quello liberale di esaltazione dell’antagonismo fra gli uomini. La concorrenza fra gli umani in onori, potere, ricchezze, nasce dal fatto che essi se per un aspetto non possono vivere da soli, sono esseri sociali come diceva Aristotele, dall’altro, vivono con gli altri valutando, invidiando e cercando di emulare le loro realizzazioni (lo Heidegger “kantiano” di Essere e tempo parlerà della “contrapposizione commisurante” come di un “esistenziale”).
“Senza la condizione, in sé certo non desiderabile, della insocievolezza, da cui sorge la resistenza che ognuno nelle sue pretese egoistiche deve necessariamente incontrare, tutti i talenti – scrive Kant – rimarrebbero in eterno chiusi nei loro germi in una vita pastorale arcadica di perfetta armonia, frugalità, amore reciproco: gli uomini, buoni come le pecore che essi menano al pascolo, non darebbero alla loro esistenza un valore maggiore di quello che ha questo loro animale domestico”.
E più avanti: “l’uomo vuole la concordia: ma la natura sa meglio di lui ciò che è buono per la sua specie: essa vuole la discordia”. L’esaltazione del conflitto, nonché la messa in scacco di ogni perfezionismo e paternalismo, è sicuramente un altro elemento forte della prospettiva liberale di Kant.
Esso presuppone un certo modo controintituitivo di pensare. Che, d’altronde, conflitto e libertà umana siano una diade inscindibile, lo aveva già intuito Niccolò Machiavelli, allorquando nei Discorsi sulla prima deca di Tito Livio (1531) aveva individuato nella divisone, e non nell’armonia e concordia (che è l’ideale di ogni teologia politica), il motivo della libertà e della forza della Roma repubblicana.
Controfattualità, inintenzionalità, rapporto dialettico fra gli elementi del mondo (e in primis fra “bene” e “male”), interconnessione fra gli stessi e realtà e verità come processualità: sono questi, come è noto, gli elementi portanti della concezione idealistica di Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Il quale, nelle lezioni di Filosofia della storia, (pubblicate postume dagli allievi nel 1837), osserverà il comporsi continuo delle azioni umane secondo un disegno non riconducibile a un progetto cosciente parlando di “astuzia della Ragione”. Necessità e razionalità, nonché finalismo, della storia, collocano in strano modo, fra immanenza e trascendenza, la visione hegeliana. Che, comunque, ha il forte merito di porre la questione su binari di profondità forse mai più raggiunti. Certo, la trascendenza della Ragione è, per così dire, tutta immanente alla storia.
Ed Hegel stesso si compiaceva di aver superato, con la dialettica, la concezione dualistica e antitetica di coppie antinomiche come immanenza – trascendenza. Nonché di aver “redento il mondo dal male”.
Sarà soprattutto l’“hegeliano” Benedetto Croce, tuttavia, a inizio Novecento, a espungere ogni elemento di trascendenza dall’immanentismo idealistico e a laicizzare e a rendere scientifici del tutto molti dei concetti su cui si reggeva la filosofia di Hegel. In primo luogo, proprio quella di una “Provvidenza” o di un “Dio”, per così dire, operanti nella storia.
La questione è posta con chiarezza, proprio come sarà fatto poi, in una prospettiva più empirica da Hayek (e prima ancora dal suo maestro Ludwig von Mises), sul terreno di una “teoria dell’azione umana”. Nella Filosofia della pratica (1909), Croce distingue l’azione dall’accadimento, dicendo che la prima è opera dell’uomo e la seconda di Dio.
È una formula immaginifica, essendo quella di Croce una filosofia che non dà spazio alcuno alla trascendenza, per indicare il fatto che la storia, che è crocianamente l’unica realtà e l’oggetto esclusivo della conoscenza, pur essendo opera delle azioni individuali degli umani, realizza risultati, gli “accadimenti” appunto, che vanno oltre le intenzioni coscienti dei singoli. Per il semplice fatto che essi sono il risultato dell’interazione, e la composizione in unicum, di tutte le azioni e intenzioni umane.
Hayek aggiungerà, da una prospettiva meno speculativa, che ogni intervento vivo e intenzionale sul corpo sociale finisce per generare non solo esiti non voluti ma anche non auspicabili. Soprattutto, in economia (ove l’ordine spontaneo è da lui anche indicato con il nome greco di catallassi).
E ciò per un principio, implicito già in Smith: nessuno possiede una conoscenza totale delle le informazioni parcellizzate e disperse fra i mille individui che compongono una società. Con un passaggio, certo non pacifico da un punto di vista teoretico, dal pensiero alla prassi (sulla linea dell’einaudiano “conoscere per deliberare”), si può perciò dire, già con lo Hayek de L’abuso della ragione (1952), che ogni programmazione o ingegneria sociale è di per sé lesiva della libertà umana. [spacer height=”20px”]
Corrado Ocone, “Il Dubbio” 10 gennaio 2018